Ma è sempre
un’altra storia: la Signora Ava di Francesco Jovine
di Fulvio Tuccillo
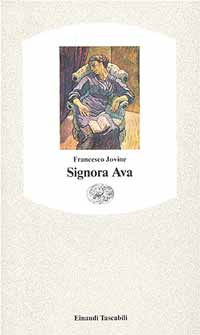 Non ha
ottenuto una gran fortuna questo romanzo di Francesco Jovine, che
può considerarsi un autentico capolavoro della letteratura
italiana del novecento. In passato contribuì a conferire una
certa notorietà a Signora Ava uno sceneggiato televisivo
di ottimo livello, del 1975, per la regìa di Antonio Calenda;
comunque è significativo il fatto che l’opera, pubblicata
per la prima volta nel 1942 da Tuminelli, figura da decenni nei cataloghi
di uno dei più grandi editori italiani. Ma è anche probabile
che tanti lettori di Cent’anni di solitudine di García
Márquez a stento conoscano il titolo di questo romanzo, che
a buon diritto e per alcuni aspetti può essere accostato al
capolavoro dello scrittore colombiano e che per di più è stato
scritto da un molisano ed è ambientato proprio in Molise, vale
a dire in terre a noi assai vicine. Chi scrive, ogniqualvolta rilegge Signora
Ava, non può fare a meno di commuoversi, di rimanere preso,
incantato da questa grande storia, da questo straordinario autore,
dotato al tempo stesso di una stupefacente attenzione verso il particolare,
di grande senso realistico e di una mirabile fantasia. La storia
d’amore di Pietro Veleno e Antonietta De Risio è bella
quanto quella di Frederic Henry e Catherine Barkley narrata da Hemingway
in Addio alle armi, pur se disegnata con tratti molto più discreti
e lievi; ma tanti dei personaggi di Jovine hanno un fascino indimenticabile,
basti pensare al vecchio Colonnello ed a Matteo Tridone, prete di campagna
vigoroso e cordiale, tuttavia tanto povero da non disdegnare nemmeno
qualche furtarello alimentare e che del prete sembra aver perso quasi
tutti i tratti esteriori, ma conserva invece ciò che veramente è essenziale,
il senso della fraternità e della carità umana. Sullo
sfondo lo scenario di una provincia meridionale al tempo stesso vivace
e sonnolenta, ma scossa in profondità dagli eventi dell’unificazione,
una provincia che conserva un senso antico di rispetto umano ed una
sua cultura che è messa a repentaglio proprio dalla guerra,
caratterizzata – come tutte le guerre – dallo sprigionarsi
di una specie di psicosi, per cui molti vogliono parteciparvi ed alla
fine tutti si trovano di fronte ad eventi dolorosi ed imprevedibili,
a sviluppi ben diversi da quelli sperati o previsti. Agli inizi la
guerra si annuncia come un evento molto più lontano di quanto
in realtà non sia, le notizie che arrivano sono imprecise e
vaghe, ma il territorio è diventato insicuro; i giovani, gli
studenti, i figli della borghesia di provincia, quasi tutti di vaghi
sentimenti liberali, tentano con ardore di armarsi, si scontrano con
le truppe borboniche sbandate e ad Isernia vengono presi in un’imboscata
(la storia ci dice che proprio Isernia fu a lungo e sanguinosamente
contesa); invece i contadini, anch’essi sbandati e timorosi di
tutto, tendono a schierarsi con i resti dell’esercito di Francesco
II, che molti di loro avevano già servito, mentre prende forma
il fenomeno del brigantaggio. Ma più che altro v’è una
grande agitazione e confusione: mentre le antiche forme di coesione
sociale resistono abbastanza bene, si susseguono imboscate, piccoli
e meno piccoli episodi di violenza, che ad alcuni costano la vita. Alla
fine qualche mano pietosa lancia i cappelli degli uccisi davanti alle
loro case, a mo’ di triste messaggio per i familiari (questo è un
particolare del romanzo che non si dimentica). Quando la situazione
politico-militare appare ormai decisa, proprio gli innocenti, come Pietro
Veleno e Carlo Antenucci, sono costretti a fuggire, per un equivoco,
per un tradimento dovuto alla paura, e si aggregano alla banda del
Sergentello, destinata ad essere pur essa sterminata dalle forze ormai
preponderanti del nascente stato unitario. Invano i pochi superstiti,
cui si sono aggiunti Antonietta De Risio e don Matteo, tentano di passare
il confine con lo stato pontificio e mettersi in salvo, perché proprio
quando sono vicinissimi alla meta vengono fermati, andando incontro
ad un destino di cui l’autore non ci dice nulla (qui si chiude
il romanzo).
Non ha
ottenuto una gran fortuna questo romanzo di Francesco Jovine, che
può considerarsi un autentico capolavoro della letteratura
italiana del novecento. In passato contribuì a conferire una
certa notorietà a Signora Ava uno sceneggiato televisivo
di ottimo livello, del 1975, per la regìa di Antonio Calenda;
comunque è significativo il fatto che l’opera, pubblicata
per la prima volta nel 1942 da Tuminelli, figura da decenni nei cataloghi
di uno dei più grandi editori italiani. Ma è anche probabile
che tanti lettori di Cent’anni di solitudine di García
Márquez a stento conoscano il titolo di questo romanzo, che
a buon diritto e per alcuni aspetti può essere accostato al
capolavoro dello scrittore colombiano e che per di più è stato
scritto da un molisano ed è ambientato proprio in Molise, vale
a dire in terre a noi assai vicine. Chi scrive, ogniqualvolta rilegge Signora
Ava, non può fare a meno di commuoversi, di rimanere preso,
incantato da questa grande storia, da questo straordinario autore,
dotato al tempo stesso di una stupefacente attenzione verso il particolare,
di grande senso realistico e di una mirabile fantasia. La storia
d’amore di Pietro Veleno e Antonietta De Risio è bella
quanto quella di Frederic Henry e Catherine Barkley narrata da Hemingway
in Addio alle armi, pur se disegnata con tratti molto più discreti
e lievi; ma tanti dei personaggi di Jovine hanno un fascino indimenticabile,
basti pensare al vecchio Colonnello ed a Matteo Tridone, prete di campagna
vigoroso e cordiale, tuttavia tanto povero da non disdegnare nemmeno
qualche furtarello alimentare e che del prete sembra aver perso quasi
tutti i tratti esteriori, ma conserva invece ciò che veramente è essenziale,
il senso della fraternità e della carità umana. Sullo
sfondo lo scenario di una provincia meridionale al tempo stesso vivace
e sonnolenta, ma scossa in profondità dagli eventi dell’unificazione,
una provincia che conserva un senso antico di rispetto umano ed una
sua cultura che è messa a repentaglio proprio dalla guerra,
caratterizzata – come tutte le guerre – dallo sprigionarsi
di una specie di psicosi, per cui molti vogliono parteciparvi ed alla
fine tutti si trovano di fronte ad eventi dolorosi ed imprevedibili,
a sviluppi ben diversi da quelli sperati o previsti. Agli inizi la
guerra si annuncia come un evento molto più lontano di quanto
in realtà non sia, le notizie che arrivano sono imprecise e
vaghe, ma il territorio è diventato insicuro; i giovani, gli
studenti, i figli della borghesia di provincia, quasi tutti di vaghi
sentimenti liberali, tentano con ardore di armarsi, si scontrano con
le truppe borboniche sbandate e ad Isernia vengono presi in un’imboscata
(la storia ci dice che proprio Isernia fu a lungo e sanguinosamente
contesa); invece i contadini, anch’essi sbandati e timorosi di
tutto, tendono a schierarsi con i resti dell’esercito di Francesco
II, che molti di loro avevano già servito, mentre prende forma
il fenomeno del brigantaggio. Ma più che altro v’è una
grande agitazione e confusione: mentre le antiche forme di coesione
sociale resistono abbastanza bene, si susseguono imboscate, piccoli
e meno piccoli episodi di violenza, che ad alcuni costano la vita. Alla
fine qualche mano pietosa lancia i cappelli degli uccisi davanti alle
loro case, a mo’ di triste messaggio per i familiari (questo è un
particolare del romanzo che non si dimentica). Quando la situazione
politico-militare appare ormai decisa, proprio gli innocenti, come Pietro
Veleno e Carlo Antenucci, sono costretti a fuggire, per un equivoco,
per un tradimento dovuto alla paura, e si aggregano alla banda del
Sergentello, destinata ad essere pur essa sterminata dalle forze ormai
preponderanti del nascente stato unitario. Invano i pochi superstiti,
cui si sono aggiunti Antonietta De Risio e don Matteo, tentano di passare
il confine con lo stato pontificio e mettersi in salvo, perché proprio
quando sono vicinissimi alla meta vengono fermati, andando incontro
ad un destino di cui l’autore non ci dice nulla (qui si chiude
il romanzo).
 In realtà Signora Ava (1942) è anche
un gran libro contro la guerra, come lo saranno poi Uomini e no di
Vittorini e La casa in collina di Pavese, ma forse ciò che
colpisce di più è la molteplicità dei piani sui
quali l’opera si articola, la grande complessità sottostante
l’apparente semplicità ed il tono di evocazione favolosa
richiamato già nel titolo (’a ’gnora Ava è un
mitico personaggio di un canto popolare), che a sua volta sembra conferire
un’amplificazione mitografica ed epico-lirica alla vicenda piuttosto
che ridurla a scenarî folclorici o localistici. Ciò che
si sa dell’accurato lavoro di documentazione storica svolto da
Jovine, della complessità dei suoi referenti culturali (significativa è la
sua familiarità con studiosi come Fortunato e Dorso ma anche
con la grande cultura dell’illuminismo meridionale, da Galiani
a Genovesi), ed anche quanto viene confermato dall’altro
suo grande romanzo Le terre del sacramento (1948), ove il taglio
storico-realistico è molto più deciso e marcato e meglio
traspare l’impegno sociale dello scrittore, chiarisce molto circa
la sua formazione ma non basta ad illuminare tutto l’orizzonte
di questo romanzo e dell’intera opera di Jovine. Anche gli interventi
critici più significativi susseguitisi nel corso degli anni
(in proposito è necessario ricordare almeno quelli di Natalino
Sapegno, Carlo Salinari, Gennaro Savarese e Francesco D’Episcopo),
sembrano lasciare larghe zone d’ombra, pur se ancora valida sembra
la prospettiva interpretativa additata a suo tempo da Carlo Salinari
che poneva l’accento sul fermento neorealistico, inteso come étos prima
ancora che come fenomeno letterario, avvicinando Jovine a scrittori
come Pavese e Levi. Il fatto è che il molisano è scrittore
complesso e ricco, di grande personalità, ma anche estremamente
sobrio, poco appariscente, umbratile, discreto. Tuttavia la
sua voce ha sempre una risonanza profonda ed inconfondibile ed è forse
la stessa che si può avvertire chiaramente in uno dei passaggi
più belli del romanzo, che può considerarsi espressione
emblematica del mondo interiore e poetico dell’autore. Si tratta
del lungo dialogo che il vecchio colonnello don Giovannino De Risio,
antico combattente napoleonico,
In realtà Signora Ava (1942) è anche
un gran libro contro la guerra, come lo saranno poi Uomini e no di
Vittorini e La casa in collina di Pavese, ma forse ciò che
colpisce di più è la molteplicità dei piani sui
quali l’opera si articola, la grande complessità sottostante
l’apparente semplicità ed il tono di evocazione favolosa
richiamato già nel titolo (’a ’gnora Ava è un
mitico personaggio di un canto popolare), che a sua volta sembra conferire
un’amplificazione mitografica ed epico-lirica alla vicenda piuttosto
che ridurla a scenarî folclorici o localistici. Ciò che
si sa dell’accurato lavoro di documentazione storica svolto da
Jovine, della complessità dei suoi referenti culturali (significativa è la
sua familiarità con studiosi come Fortunato e Dorso ma anche
con la grande cultura dell’illuminismo meridionale, da Galiani
a Genovesi), ed anche quanto viene confermato dall’altro
suo grande romanzo Le terre del sacramento (1948), ove il taglio
storico-realistico è molto più deciso e marcato e meglio
traspare l’impegno sociale dello scrittore, chiarisce molto circa
la sua formazione ma non basta ad illuminare tutto l’orizzonte
di questo romanzo e dell’intera opera di Jovine. Anche gli interventi
critici più significativi susseguitisi nel corso degli anni
(in proposito è necessario ricordare almeno quelli di Natalino
Sapegno, Carlo Salinari, Gennaro Savarese e Francesco D’Episcopo),
sembrano lasciare larghe zone d’ombra, pur se ancora valida sembra
la prospettiva interpretativa additata a suo tempo da Carlo Salinari
che poneva l’accento sul fermento neorealistico, inteso come étos prima
ancora che come fenomeno letterario, avvicinando Jovine a scrittori
come Pavese e Levi. Il fatto è che il molisano è scrittore
complesso e ricco, di grande personalità, ma anche estremamente
sobrio, poco appariscente, umbratile, discreto. Tuttavia la
sua voce ha sempre una risonanza profonda ed inconfondibile ed è forse
la stessa che si può avvertire chiaramente in uno dei passaggi
più belli del romanzo, che può considerarsi espressione
emblematica del mondo interiore e poetico dell’autore. Si tratta
del lungo dialogo che il vecchio colonnello don Giovannino De Risio,
antico combattente napoleonico,  veterano della campagna di Russia,
poi carbonaro postosi agli ordini del generale Pepe, ed inoltre intellettuale
di provincia direttore e docente di una scuola privata molto frequentata,
versificatore rinomato ma soprattutto filosofo autentico, ha, quasi
in punto di morte, con l’amico Matteo Tridone, quest’originale
prete di campagna cui tutti vogliono bene; dialogo del quale riporto
qualche brano particolarmente significativo: «Confusione, Matteo;
buono, cattivo, angelico, diabolico, fingere, credere, dubitare, sperare:
ogni tanto tutto si fonde; per un attimo nasce l’armonia […]
Io ho cercato di inseguire quell’armonia poche volte udita, non
ho voluto mai con la mia volontà impedire che nascesse in me
o intorno a me. Il male, Matteo, mi ha aggredito sempre di sorpresa:
quando l’ho visto non ho potuto mai far niente per impedirlo.
Siamo così deboli, Matteo caro, così deboli». Anche
il mondo di Jovine, come quello di Verga — per riprendere quanto
diceva Croce dello scrittore siciliano — è nutrito di
bontà e malinconia, ed ovviamente di grande intelligenza: Signora
Ava non è solo un romanzo della memoria, popolato dalle
mille voci e storie della cultura popolare, non è solo la struggente
elegia di un’antica provincia meridionale, è pure un’opera
di straordinaria ricchezza, anch’essa caratterizzata da quel
bisogno fortissimo di dar vita ad una cultura rinnovata che forse fu
il segno più caratteristico ed alto della stagione in cui operarono
scrittori come Vittorini e Pavese, Silone e Levi.
veterano della campagna di Russia,
poi carbonaro postosi agli ordini del generale Pepe, ed inoltre intellettuale
di provincia direttore e docente di una scuola privata molto frequentata,
versificatore rinomato ma soprattutto filosofo autentico, ha, quasi
in punto di morte, con l’amico Matteo Tridone, quest’originale
prete di campagna cui tutti vogliono bene; dialogo del quale riporto
qualche brano particolarmente significativo: «Confusione, Matteo;
buono, cattivo, angelico, diabolico, fingere, credere, dubitare, sperare:
ogni tanto tutto si fonde; per un attimo nasce l’armonia […]
Io ho cercato di inseguire quell’armonia poche volte udita, non
ho voluto mai con la mia volontà impedire che nascesse in me
o intorno a me. Il male, Matteo, mi ha aggredito sempre di sorpresa:
quando l’ho visto non ho potuto mai far niente per impedirlo.
Siamo così deboli, Matteo caro, così deboli». Anche
il mondo di Jovine, come quello di Verga — per riprendere quanto
diceva Croce dello scrittore siciliano — è nutrito di
bontà e malinconia, ed ovviamente di grande intelligenza: Signora
Ava non è solo un romanzo della memoria, popolato dalle
mille voci e storie della cultura popolare, non è solo la struggente
elegia di un’antica provincia meridionale, è pure un’opera
di straordinaria ricchezza, anch’essa caratterizzata da quel
bisogno fortissimo di dar vita ad una cultura rinnovata che forse fu
il segno più caratteristico ed alto della stagione in cui operarono
scrittori come Vittorini e Pavese, Silone e Levi.
Fulvio
Tuccillo

