 Un
libro al mese Un
libro al mese
 Percorsi
bibliografici Percorsi
bibliografici
 |
Invito
alla lettura di Mario dell'Arco
di
Fulvio Tuccillo
|
|
La
poesia dialettale viene di solito ritenuta un genere letterario particolare,
un’espressione legata a realtà locali,
spesso caratterizzata dalla mimesi dei materiali più tipici
della tradizione popolare. Ma questa consolidata opinione trova una
smentita immediata proprio nelle vicende storiche della poesia del
novecento. Non è solo la presenza, alle sue scaturigini, di
alcuni grandissimi, come i nostri Di Giacomo e Russo, ma soprattutto
il succedersi – in tempi molto più recenti – di
nomi di scrittori di primissimo piano (Pasolini, Marin, Noventa,
Giotti, Loi, Guerra, Pierro, Zanzotto e tanti altri), spesso abili
ad usare il dialetto come l’italiano, a confermarci che molti
poeti contemporanei hanno scelto il dialetto come lingua capace
di dar voce al loro mondo interiore. Si potrebbe sostenere che ciò accada
per la necessità di sfuggire al tirannico dominio dei linguaggi
serializzati e mediatizzati, pur se anche il dialetto si rivela poi
una risorsa precaria, quasi un regno della memoria, dato che nella
realtà il suo uso quotidiano tende inesorabilmente a restringersi
ed impoverirsi. Ed infatti i poeti contemporanei di solito sentono
il dialetto più come personale lingua poetica che come linguaggio
atto a designare e rappresentare una particolare realtà, quindi
rifuggono proprio da quelle tentazioni bozzettistiche o veristiche
che il ricorso ad esso sembra suggerire, affrancandosi anche da strette
dipendenze di tipo linguistico o stilistico. In certo senso è vero
quanto affermava Croce a proposito del prediletto Di Giacomo, vale
a dire che «molta parte dell’anima nostra è dialetto» e
che, quindi, la scelta di poetare in dialetto non solo è pienamente
legittima, ma è anche qualcosa che sfugge ad una precisa intenzionalità o
causalità. D’altronde è anche vero che l’opzione
dialettale non è del tutto neutra, ci condiziona perché ogni
linguaggio ha il suo particolare spirito, la sua tradizione ed una
sua storia che è pure quella degli autori che l’hanno
fatta grande. Questo vale particolarmente nel caso del romanesco che,
appunto in quanto aperto al continuo influsso dell’italiano,
non ha un ambito chiuso e riservato e dagli specialisti non viene nemmeno
considerato un dialetto vero e proprio. Tuttavia il romanesco resta
la lingua del grande Belli, «poeta saturnino, ribelle fino all’eversione
nei suoi versi» e capace di descrivere ogni aspetto dell’animo
umano (questo è il mirabile ritratto che ne veniva fatto a suo
tempo da Primo Levi), una lingua spesso caratterizzata dal sarcasmo
e dall’iperbole e che lo stesso Belli non esitava a definire «gretta,
sconcia, abietta e buffona favella».
Ma
il romanesco è anche la lingua
di Mario dell’Arco, forse il maggior poeta dialettale romano
del nostro Novecento (ed a parere di molti uno tra i maggiori del secolo
scorso), che è stato capace di conferire ad esso una particolare
leggerezza, senza privarlo della sua vis ironica ma impiegandola
invece come un tramite per dar voce a certe sottili vibrazioni dell’anima
con apparente nonchalance, per costruire metafore ed allegorie
di rara bellezza, per disegnare degli straordinari chiaroscuri. Rileva
in proposito uno specialista come Pietro Gibellini, facendo riferimento
ad un testo specifico, Il Vangelo secondo Mario dell’Arco,
che qui «il linguaggio si fa addirittura più leggero dell’italiano» e
che le «le poche tracce dialettali […] servono addirittura
a rendere più scorrevole il soliloquio».
Dell’Arco
per la verità resta
tuttora un enigma letterario non pienamente disvelato. Mario Fagiolo
(questo il suo vero nome) nasceva nel 1905 a Roma da una famiglia originaria
di Genzano. Il nonno Giovanni era proprietario di vigne ed aveva aperto
ben tredici osterie per meglio smerciare il suo vino, il padre Cesare – di
fronte ad un improvviso tracollo di quest’attività – si
era improvvisato egli stesso oste senza mai amare il suo lavoro. Dopo
aver compiuto i primissimi studî presso scuole tenute da suore
tedesche ed inglesi, il giovanissimo Mario aveva riscoperto – forse
per contrapposizione – la
dolcezza della parlata materna e poi aveva pubblicato le prime raccolte
di poesie, Io
e Nina ed Enrico Toti-Sonetti romaneschi, rispettivamente
nel 1924 e nel 1925. Nel 1928 Mario Fagiolo si laureava in architettura
ed iniziava una carriera abbastanza fortunata (tra l’altro è suo
il progetto del palazzo delle Poste di Piazza Bologna a Roma); una
carriera tuttavia destinata ad esaurirsi quando egli scopriva una vocazione
più forte e prepotente, quella di poeta. I veri e propri esordi
poetici di dell’Arco avvengono però molto più tardi, con
la raccolta Taja ch’è rosso,
che appare nel 1946 con prefazione di Antonio Baldini. Qui lo scrittore
impiega per la prima volta il fortunato pseudonimo che ci rimanda alla
sua professione, quasi a suggellare il distacco dalla produzione precedente;
nello stesso anno rifiuta la paternità artistica degli
scritti anteriori al ’45. Critici come Trompeo, Baldini, Mazzocchi
Alemanni immediatamente si rendono conto della novità della
sua poesia ed è Trompeo a definire dell’Arco – in
un intervento che poi è stato all’origine di tutta una
tradizione critica – «la più limpida voce di poeta
che da Trilussa in qua si sia sentita nel nostro dialetto»; ma
Trompeo fa rilevare anche come dell’Arco già superi la
dimensione tradizionale della dialettalità, rinunciando pure
a certi artifici che di questa tradizione erano parte. Poco più tardi
lo stesso Pasolini, che insieme a dell’Arco sarà curatore
di quella fortunata Antologia della poesia dialettale pubblicata
da Guanda nel 1952, sottolineerà con più forza questi
caratteri della sua opera poetica. A questi riconoscimenti si uniranno
poi quelli di Contini, Bo, Bocelli, Petrocchi, Sciascia, don Giuseppe
De Luca e di molti altri. V’è da aggiungere però che,
se la lunga attività poetica di Mario dell’Arco dura fino
al 1995 (anno della scomparsa), tuttavia la sua opera a tale data appariva
ancora dispersa in una vasta serie di piccole e talvolta minuscole
raccolte, all’incirca cinquanta, alcune delle quali ripresentavano
insieme ai nuovi lavori composizioni già edite. Insomma – per
circa quarant’anni – l’architetto Mario Fagiolo,
se da una parte intraprendeva anche un’instancabile e minuta
attività editoriale, dall’altra accuratamente evitava
di costruirsi quel monumentum aere perennius che avrebbe dovuto
consacrare definitivamente la sua fama e tramandarla ai posteri. Forse è proprio
questo rifuggire dagli alienanti meccanismi della consacrazione letteraria
e del successo, cui contradditoriamente si accompagna una predilezione
per una diffusione editoriale minuta e quasi amicale, uno dei segni
più tipici dell’autenticità della sua vocazione
poetica. Si può supporre inoltre che dell’Arco condividesse
con molti scrittori contemporanei una fede ostinata, una generosa illusione
che talvolta si è rivelata esiziale per il destino della loro
opera: la convinzione che la poesia, che è nel mondo, che è di
tutti, sia destinata a sopravvivere comunque, appunto perché esprime
qualcosa di universale che non può essere subordinato alle sue
manifestazioni empiriche, ad una fenomenologia editoriale. Tra i tanti «sommersi»,
vittime di questa nobile ostinazione, vorrei ricordare almeno il nome
di Vincenzo Borelli, scrittore dotato di autentico e profondo
talento.
 Comunque,
rispetto alla situazione editoriale appena descritta, sicuramente
provvidenziale appare l’iniziativa
presa dal Comitato per la celebrazione del centenario di Mario dell’Arco
di riunirne tutte le poesie in un bel volume curato da Carolina Marconi,
arricchito dai contributi di Pietro Gibellini e Franco Onorati e pubblicato
dall’editore Gangemi (Mario dell’Arco, Tutte le poesie
romanesche. 1946-1995, Roma, Gangemi, 2005). Comunque,
rispetto alla situazione editoriale appena descritta, sicuramente
provvidenziale appare l’iniziativa
presa dal Comitato per la celebrazione del centenario di Mario dell’Arco
di riunirne tutte le poesie in un bel volume curato da Carolina Marconi,
arricchito dai contributi di Pietro Gibellini e Franco Onorati e pubblicato
dall’editore Gangemi (Mario dell’Arco, Tutte le poesie
romanesche. 1946-1995, Roma, Gangemi, 2005).
Ma
quanto si diceva in precedenza serve anche a confermarci la particolare
condizione di questa poesia, che sembra alimentarsi di nulla e sopravvivere
ed illuminarsi in uno scenario straordinario, che avrebbe potuto
anche oscurarla o – peggio – banalizzarla
(quello dell’aeterna urbs, che forse è tale anche
e soprattutto nel nostro inconscio, ben oltre le convenzioni retoriche).
Dell’Arco, come nessun altro forse, riesce a ridar vita ai monumenti
ed ai luoghi illustri di Roma, che in certo senso diventano anch’essi
elementi di uno scenario naturale: piccoli capolavori sono Piazza
Navona, ove anche «le bestie de marmo, aria a le gamme» entrano
a far parte del «bailamme», e La quercia der Tasso,
che «esce su la stampella / e poi se ferma co’ la mano
stesa, / a un passo da la chiesa, / come una poverella» (ivi,
p. 12). Un esempio particolarmente significativo è poi quella
straordinaria Via Crucis che il poeta immaginariamente ripercorre
in Ponte dell’Angeli (ivi, pp. 52-55). Il celebre
scenario del ponte, con ognuno degli angeli che ci rimanda ad una tappa
della Via Crucis, sembra quasi dissolversi in una viva ed a
tratti quasi sconvolgente rimeditazione della Passione, che la rende
a noi contemporanea, perché essa diventa la passione di ogni
uomo; e così anche gli angeli, dispersi dal vento come «na
manciata de farfalle» (si tratta di un evidente paradosso
dato che nella realtà sono statue marmoree) riacquistano la
loro natura eterea. Nel quadro successivo, La basilica, pure
gli apostoli sono pienamente umanizzati: «Indove sta Matteo?
/ E Andrea, e Giovanni, e Giacomo, e Taddeo? / Troppo straccioni co
na vesta sola / rittoppata, e la sola / der sannalo sfonnata. / Stanno
de fora, all’aqua, ar vento, ar gelo: / sur cornicione, e la
capoccia in celo» (ivi, p. 55) e Gesù stesso si
fa «omo in un gregge d’omini», che diventa «più fitto», «più strappato,
più rognoso». Come Belli, dell’Arco, se ripudia
le espressioni esteriori e rituali della religione cattolica (si veda
in questo senso La porta) e registra con lucida angoscia la
lontananza di Dio dall’uomo e dell’uomo da Dio, tuttavia
rimedita in profondità il messaggio cristiano umanizzandonene
le manifestazioni più significative, pur se sostanzialmente
rinuncia ai corrosivi sarcasmi così cari al grande poeta ottocentesco.
Il punto più significativo di questo complesso atte ggiamento
sembra consistere proprio in un attonito soffermarsi di fronte ai grandi
interrogativi del cristianesimo, che dell’Arco sente come drammaticamente
attuali anche per l’uomo moderno, malgrado il suo radicale scetticismo,
il suo totale immanentismo. Forse nemmeno a dell'Arco
si potrebbe chiedere una professione di fede (perché fede non
v’era) eppure nessuno è andato più avanti
di lui – ha scritto recentemente Franco Onorati – riguardo
alla «umanizzazione della scrittura, all’incarnazione di
Cristo nella storia, alla condivisione della condizione umana». ggiamento
sembra consistere proprio in un attonito soffermarsi di fronte ai grandi
interrogativi del cristianesimo, che dell’Arco sente come drammaticamente
attuali anche per l’uomo moderno, malgrado il suo radicale scetticismo,
il suo totale immanentismo. Forse nemmeno a dell'Arco
si potrebbe chiedere una professione di fede (perché fede non
v’era) eppure nessuno è andato più avanti
di lui – ha scritto recentemente Franco Onorati – riguardo
alla «umanizzazione della scrittura, all’incarnazione di
Cristo nella storia, alla condivisione della condizione umana».
Anche
da questo punto di vista, per questa meditazione intensa e tesa,
spesso scetticamente desolata ma sempre in qualche modo partecipe,
del messaggio evangelico si potrebbe sostenere che dell’Arco
si avvicina a Pascoli (un’indicazione che
rimandava a Pascoli v’era già nel saggio di Trompeo),
pur se è proprio la luminosa solarità dei suoi versi
a farne un personaggio tanto diverso dal poeta romagnolo. Ma a Pascoli
dell'Arco si accosta sicuramente anche per un’altra
ragione: perché i suoi versi il più delle volte sembrano
fatti di materia lieve, quasi impalpabile, eppure creano un’atmosfera
inconfondibile, ci comunicano un universo di sensazioni e di riflessioni.
Dell’Arco è un
poeta che va conosciuto a fondo e che si nasconde ad una lettura superficiale.
I suoi frammenti, presi uno per uno, non ci trasmettono sensazioni
forti, ma nel loro complesso, oppure fruiti nei vari contesti tematici,
ci comunicano un’emozione intensa, piena, il senso di un mondo
che è totum suum. E poi è anche un autentico maestro
nella tecnica dell’understatement, un finissimo
letterato che sa dispensarci citazioni coltissime alla chetichella,
con consumata dissimulazione. Sono tutti da leggere i suoi Marziale,
Catullo, Orazio, autentiche versioni in romanesco e non semplici traduzioni,
molto spesso interpretazioni lontane dall’originale che ci aiutano
a riscoprirlo meglio di tante e tante versioni letterarie. Pertanto
non posso fare a meno di dispensare al lettore due brani da Marziale,
diciamo tra i più innocenti, e malgrado ciò irresistibili.
Il primo: «Nun te la presto mille lire, ma / te n’arigalo,
Biacio, cinquecento. / Pijele! Me contento / de perde la metà»,
che rende il testo di Marziale: «Dimidium donare Lino quam credere
totum / qui mavolt, mavolt perdere dimidium». Ed il secondo,
molto più corrosivo: «La sora Pasqualina ha sotterrato
/ sei mariti: sei moje er sor Pasquale. / Famo sto pangrattato / subbito,
e risparmiamo un funerale», che rende con l’impagabile
evocazione del pangrattato un luogo di Marziale molto più severo
(da Marziale per un mese, ivi, pp. 144-45). Potrei continuare
così a lungo, ma basti dire che l’altra raccolta dedicata
a Marziale s’intitola Fatemi divertire. Marziale per un altro
mese.
Poi
v’è un dell’Arco
di assoluta e classica purezza, quello a me più caro. È il
poeta di Acqua e celo: «Usciva l’acqua a goccia
/ a goccia da la roccia. / Ancora resta er gelo / dentro a le mano
unite – e bevo ancora / come allora acqua e celo» (ivi, p.
221). Oppure quello che affronta la vita ed il dolore, consapevole
di essere parte di un tutto, del mondo meraviglioso, incomprensibile,
terribile. E di questo dell’Arco si potrebbe ben dire quanto
affermava Cesare Pavese di Melville. Infatti Pavese definiva lo scrittore
americano «un greco» per sottolinearne la profonda cultura, che
gli permetteva di iniziare persino Moby Dick, «il
poema della vita barbara», con lunghe pagine di citazioni, ma
poi evidenziava come Melville riportasse sempre il lettore ai liberi
orizzonti della vita vissuta, alla sua aria vivificante. Questo dell’Arco è il
poeta semplicissimo di Paura d’essè solo: «Paura
d’èsse solo. / Invento un’osteria – e pesco
a volo / un amico: un amico / pronto a divide (spero) / un pensiero
sereno. / Odor de vino – e / a la salute! Dico: / ma er tavolino è vòto
avanti a me / in mano a me er bicchiere resta pieno» (p. 297);
anche il poeta che si sofferma a descrivere con scherzosa affettuosità il
mondo della natura e le sue presenze: i gatti, gli uccelli (era un
fermo osteggiatore della caccia), gli olmi. Un uomo che dentro di sé ha
conservato sempre qualcosa dell’adolescenza: «Un chiodo
e un chiodo a fonno / ar tronco: l’ormo era / un arbero de nave – e
er regazzino, leggero er piede, la mano  leggera / er padrone der monno.
/ Er chiodo m’incoraggia a la scalata: / ma la mano è de
piommo, / de piommo er piede. L’ormo / è una nave arenata.
/ Anni e anni cammino, / dentro a me / chiuso un ormo: finché /
ritrovo er colle, ritrovo l’ormata. / L’ormo pianta le
radiche / e ogni rama formìccica de foje. / Io pianto er piede
e subbito se scioje / dar core la brinata» (Ormo più ormo
uguale a ormo, ivi, pp. 185-86). Indimenticabile è poi
il poeta degli affetti perduti: la madre e soprattutto il figlioletto
mortogli in tenera età. Così, con un’immagine di
straordinaria semplicità, egli ricorda la madre: «Un regazzino
fermo / sempre a l’istessa età. / M’affido ancora
a te / ancora m’ariggiro / come in un nido ner respiro tuo //
Poche e gnente parole / t’ho detto. Adesso troppe / e s’affolleno
in gola. / Inutile che aspetto la risposta / Sbatte contro er silenzio
ogni parola / e come un sasso m’arimbarza in petto» (A
mia madre, ivi, p. 295). Ed è la mancanza del figlio
a riproporgliene ogni volta la presenza: «Er pupo è ritornato
/ su una striscia de sole. Sento er fiato / e la pelle ch’è un
raso: / aspetto le parole. / E me trovo che faccio a naso naso co una
striscia de sole» (Una striscia de sole, ivi, pp. 26-27).
Il trenino, il cavallo a dondolo, la barchetta di carta, la trombetta,
il gioco della conchiglia, la ninnananna ci riportano ad attimi di
vita nei quali rivive una presenza ed una mancanza, che rallegrano
e dilaniano, riproponendo il lacerante paradosso dell’esistenza
e del tempo. Allora non stupisce che ancora una volta l’invocazione
si tramuti in rimprovero, quasi in invettiva e la speranza in disillusione,
come ne La tempesta oppure in Lazzaro, oppure ancora
ne Il Vangelo secondo Mario dell’Arco:«Quanto hai
detto, Gesù, / stampata addosso l’ombra d’una croce,
/ è scritto ner Vangelo. / Io nun so lègge: io nun vojo
lègge. / Più fermo d’uno scojo, / l’occhi
ancorati ar celo, / aspetto er lampo de la voce tua» (Vangelo
secondo Mario dell’Arco, ivi, p. 281). Dell’Arco
canta il dolore che è anch’esso vita, che si manifesta
anch’esso come un raggio di sole: «Finchè punti
un ditino ar sole, intorno / è sempre giorno e er core / come
una meridiana segna l’ore» (È sempre giorno,
ivi, p. 132). leggera / er padrone der monno.
/ Er chiodo m’incoraggia a la scalata: / ma la mano è de
piommo, / de piommo er piede. L’ormo / è una nave arenata.
/ Anni e anni cammino, / dentro a me / chiuso un ormo: finché /
ritrovo er colle, ritrovo l’ormata. / L’ormo pianta le
radiche / e ogni rama formìccica de foje. / Io pianto er piede
e subbito se scioje / dar core la brinata» (Ormo più ormo
uguale a ormo, ivi, pp. 185-86). Indimenticabile è poi
il poeta degli affetti perduti: la madre e soprattutto il figlioletto
mortogli in tenera età. Così, con un’immagine di
straordinaria semplicità, egli ricorda la madre: «Un regazzino
fermo / sempre a l’istessa età. / M’affido ancora
a te / ancora m’ariggiro / come in un nido ner respiro tuo //
Poche e gnente parole / t’ho detto. Adesso troppe / e s’affolleno
in gola. / Inutile che aspetto la risposta / Sbatte contro er silenzio
ogni parola / e come un sasso m’arimbarza in petto» (A
mia madre, ivi, p. 295). Ed è la mancanza del figlio
a riproporgliene ogni volta la presenza: «Er pupo è ritornato
/ su una striscia de sole. Sento er fiato / e la pelle ch’è un
raso: / aspetto le parole. / E me trovo che faccio a naso naso co una
striscia de sole» (Una striscia de sole, ivi, pp. 26-27).
Il trenino, il cavallo a dondolo, la barchetta di carta, la trombetta,
il gioco della conchiglia, la ninnananna ci riportano ad attimi di
vita nei quali rivive una presenza ed una mancanza, che rallegrano
e dilaniano, riproponendo il lacerante paradosso dell’esistenza
e del tempo. Allora non stupisce che ancora una volta l’invocazione
si tramuti in rimprovero, quasi in invettiva e la speranza in disillusione,
come ne La tempesta oppure in Lazzaro, oppure ancora
ne Il Vangelo secondo Mario dell’Arco:«Quanto hai
detto, Gesù, / stampata addosso l’ombra d’una croce,
/ è scritto ner Vangelo. / Io nun so lègge: io nun vojo
lègge. / Più fermo d’uno scojo, / l’occhi
ancorati ar celo, / aspetto er lampo de la voce tua» (Vangelo
secondo Mario dell’Arco, ivi, p. 281). Dell’Arco
canta il dolore che è anch’esso vita, che si manifesta
anch’esso come un raggio di sole: «Finchè punti
un ditino ar sole, intorno / è sempre giorno e er core / come
una meridiana segna l’ore» (È sempre giorno,
ivi, p. 132).
Ma
se è vero che ogni poeta è legato
ad un posto, ad una città e lo è in modo particolare,
bisogna aggiungere che una delle cose che più affascinano nella
poesia di Mario dell’Arco è proprio l’aprirsi di
un orizzonte libero, luminoso fra i monumenti e le piazze di Roma,
una Roma che a sua volta si espande verso le borgate e poi la campagna
(del resto proprio Tormarancio, che trae ispirazione dalla vita
dell’omonima borgata, è delle sue più note composizioni
e dà poi il titolo ad un’intera raccolta). Il dell’Arco
che rivisita i luoghi più belli e famosi di Roma, è anche
il poeta di Genzano che «beve fiori e vino», ancora una
volta un “provinciale” che fa grande la letteratura di
Roma proprio come l’avevano fatta grande secoli prima Terenzio,
Catullo, Orazio, Marziale, Giovenale, tutti venuti da province vicine
o lontane. Anche da questo punto di vista dell’Arco si rivela
dunque un funambolico angelo della poesia – per riprendere l’immagine
a suo tempo proposta da Trompeo, che si riferiva alle “trovate” del
poeta – capace veramente di far versi con un niente, di darci
delle costruzioni di straordinaria leggerezza, che tali rimangono anche
quando sono – per la loro stessa concezione – ricche e
complesse. Si veda ad esempio quell’affresco straordinario che è La
peste a Roma (1952), con i quadri indimenticabili del convento,
del bordello, della fossa, di grandezza quasi epica. Non sfuggirà che
qui dell’Arco si cimenta con illustri predecessori, da Tucidide
a Manzoni, a Camus. Quindi non può costituire nemmeno motivo
di stupore il fatto che gli interpreti della sua poesia siano rimasti
quasi perplessi di fronte alla varietà ed alla plasticità dei
suoi toni, riproponendone immagini talvolta molto differenziate (ad
esempio si è parlato di un dell’Arco «decadente» oppure
di un dell’Arco «barocco»). Ed allora forse si comprende
meglio anche perché dell’Arco spesso ripubblicasse le
poesie di una raccolta in quella successiva, quasi come se volesse
proporci non una serie di frammenti ma un continuum, un orizzonte
complesso e polìcromo.
Le
immagini sono state tratte dal volumetto Parole
e musica. Omaggio a Mario dell’Arco nel centenario della
Nascita, pubblicato a cura del Comune di Roma e del Centro
Studi Giuseppe Gioachino Belli (Roma, 2005) e dal libro di Franco
Onorati La
stagione romanesca di Leonardo Sciascia. Fra Pasolini e Dell'Arco (Milano, 2003)
1. Mario dell'Arco
2. La copertina di Er presepio de mamma
3. Copertina di Purificato per edizione delle Poesie del 1949
4. Copertina di Emilio Greco per La peste a Roma (Roma, 1952)
5. La copertina di Dietro una frasca
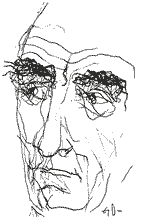
|
Indicazioni
bibliografiche
Le
indicazioni
bibliografiche relative alle citazioni di opere di dell’Arco
sono nel testo. Per gli altri luoghi citati cfr. B. CROCE, Salvatore
Di Giacomo, in La
letteratura della Nuova Italia. Saggi critici, III,
Bari, Laterza, 1943 (4. ed.), p. 99; la prefazione di
Pietro Gibellini a Tutte
le poesie romanesche cit., p. XII; P. LEVI, La
pietà nascosta
sotto il riso, in La ricerca delle radici. Antologia
personale, Torino,
Einaudi, 1981, p. 165; C. PAVESE, Hermann Melville,
in La
letteratura americana e altri saggi, Torino, Einaudi, 1990,
p. 75. L’articolo di Trompeo è riportato
da Franco Onorati nel suo lavoro su La fortuna critica di
Mario dell’Arco che compare nel volume Tutte le
poesie romanesche;
l’indicazione originale è tuttavia la seguente:
P. P. Trompeo, Nuova poesia romanesca, in «La
Nuova Europa»,
gennaio 1946. Per le considerazioni sull’atteggiamento
di dell’Arco verso il cristianesimo cfr. F. Onorati, Il
Vangelo secondo Mario dell’Arco, ne Il sacro nella
letteratura in dialetto romanesco. Da Belli al Novecento,
Roma, Edizioni Studium, 2003, p. 255. D’altronde non è possibile
fornire in questa sede un quadro complessivo dei contributi
critici relativi alla poesia di Mario dell’Arco, appunto
per il loro numero e la loro varietà.
A sinistra: Un ritratto a matita di E. Dragutescu |
|
 |
Altre
notizie e riferimenti Mario
dell’Arco ha sempre nutrito uno spiccato interesse per la
musica ed anche nel periodo precedente al 1945 - quando non aveva
ancora assunto il suo nome d’arte - ha scritto il testo
di varie canzoni in collaborazione con musicisti come Lay, Zuccoli
e Luzi (anch’esse, dunque, fanno parte della produzione di
cui poi non ha riconosciuto la paternità artistica). Fra
queste canzoni di genere melodico e gusto tradizionale scritte
anteriormente al 1945 la più famosa è «Pupo
biondo». Ma anche successivamente dell’Arco si è cimentato
con la musica: una recente e significativa riscoperta sono le Cinque
poesie romanesche musicate nel 1946 da Mario Castelnuovo-Tedesco,
bravissimo musicista rifugiatosi nel 1939 negli Stati Uniti,
in conseguenza delle persecuzioni razziali. Queste notizie insieme
ad una dettagliata ricostruzione dello sviluppo degli interessi
musicali e dell’attività di paroliere di Mario dell’Arco
si possono leggere nel volumetto Parole e musica. Omaggio
a Mario dell’Arco nel centenario della Nascita, pubblicato
a cura del Comune di Roma e del Centro Studi Giuseppe Gioachino
Belli in occasione della manifestazione svoltasi il 14 dicembre
2005 presso il teatro Valle di Roma; da questa stessa opera sono
state riprodotte alcune delle immagini che corredano questo lavoro.
A
sinistra: La copertina di Pupo biondo |
© Biblioteca
Nazionale di Napoli (giugno
2006)
I
testi pubblicati sono di proprietą della Biblioteca Nazionale
di Napoli (Ministero per i Beni e le Attivitą Culturali).
E' concessa la riproduzione parziale citando la fonte.
|

